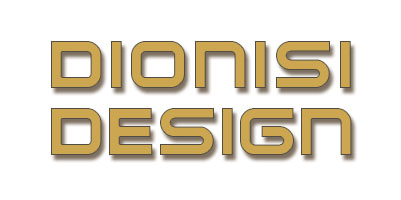Il paesaggio italiano e le periferie dei centri storici sono abbelliti da migliaia di ville e residenza che costituiscono una delle maggiori attrazioni per chi desidera gustare lo stile di vita italiano, fino ad immergersi nella dolce vita. In aggiunta le tipiche costruzioni dell’architettura rurale sono divenute di recente la residenza di riferimento per il ritorno alla natura. Di seguito alcuni esempi di residenze di campagna.
Ville di campagna
Nel Quattrocento ha origine il significato moderno di «villa» che genericamente può essere indicata come una tipologia abitativa ampia ed elegante, circondata da un giardino o parco più o meno estesi.
Il prototipo della “villa” è più antico, risale all’epoca romana, che era insieme centro di organizzazione agricola e luogo di svago. Il carattere rurale di queste residenze si perde nel Medioevo con il prevalere delle fortificazioni, dovute alle impellenti necessità difensive di quei tempi.
Nel XV secolo i castelli e le varie residenze fortificate cominciano a perdere i connotati di puri e semplici luoghi di difesa per modificarsi, ad esempio, nelle più ariose strutture dei casini di caccia.
Una delle caratteristiche dell’architettura delle ville è il riuso di edifici preesistenti. Il problema della trasformazione degli spazi è risolto a volte con un mascheramento totale, che non implica però la completa distruzione (rara sia per motivi economici che di fedeltà storica).
Eredi naturali dei casini di caccia sono le piccole «ville di delizia» cinquecentesche, che abbinano il recupero delle parti storiche a nuovi spazi, con ampie stanze e numerose logge.
La villa seicentesca sviluppa valenze architettoniche recanti un gusto accentuato per il monumentale. L’edificio diventa imponente e le ricche decorazioni solitamente esaltano le imprese e le virtù della famiglia. Ad alleggerire i fasti delle ville, nascono i leziosi giardini all’italiana, la cui moda prosegue fin nel pieno Settecento. Purtroppo questa moda verrà sostituita (e causerà perdite gravi) dalla predilezione per il giardino romantico all’inglese. Non si tratta solo di una mera differenza di stili: al giardino razionale, simbolo del dominio dell’uomo sul cosmo, subentra il parco come contemplazione della natura «selvaggia», una sorta di ritorno allo stato di natura teorizzato da Rousseau.
Casa Romita – Questa villa, costruita nel 1885, è una magnifica testimonianza delle capacità costruttive ed architettoniche tardo ottocentesche. Le possenti strutture edificate in pietra e mattoni non gravano minimamente sull’armonia delle facciate. La presenza delle due torri, San Gregorio e Sant’Andrea, delle quali l’ultima provvista di pregevole campana in bronzo, accresce il fascino architettonico della villa donandole l’aspetto di una costruzione ben più antica
Villa Vecchiarelli – La villa è posta in posizione panoramica sulle colline in prossimità della città di Rieti, e gode di una stupenda vista sul complesso montuoso dl Terminillo e sugli insediamenti medioevali arroccati sulle sue pendici.
La villa è a forma quadrangolare con spigoli evidenziati da torrioni di forma in parte curva ed in parte retta che vogliono conferirgli un aspetto di fortezza, secondo una tendenza culturale romantica dell’ottocento. Il giardino, attraversato da un vialetto in asse con la rampa centrale della scala e la fontana, termina in una piccola terrazza panoramica che si affaccia sul paesaggio circostante. La muratura esterna è in pietrame irregolare con ricorsi di mattoni, marcapiani e cornici delle finestre in mattoni. In origine la villa poteva essere intonacata, come ancora è possibile vedere nella nicchia di sinistra della facciata di ingresso
Villa Fiorenza – La villa, ristrutturata di recente, consiste in un edificio principale ed in un edificio più piccolo posto sul lato Est. L’edificio principale è disposto su 3 livelli: al piano terra si trova l’ampio ingresso fornito di bagno di servizio, un soggiorno ed una grande cucina provvista di saletta vetrata per il pranzo. Al 1° piano troviamo un soggiorno con balcone dal quale si accede da un lato alla camera da letto e dall’altro al grande bagno con cabina armadio. Sempre dal soggiorno del 1° piano si accede all’ampia mansarda suddivisa in 3 ambienti. Sul lato Est della villa è stato realizzato un piccolo appartamento fornito di accesso indipendente e costituito da soggiono, cucina con cantina, camera e bagno.
Gli ambienti sono stati decorati ed arredati con grande gusto: dipinti, tappeti, lampadari ed ogni altro elemento dell’arredo contribuiscono a rendere questa residenza davvero unica.
Rustico - Casale
“La casa rurale è uno strumento di lavoro; il più importante e più vivo strumento di lavoro che l’anima del contadino si costruisce e dello strumento di lavoro ha le caratteristiche: nulla è inutile, niente vi è di superfluo, tutto è nato per una necessità. L’impiego logico dei materiali, la distribuzione dei volumi, l’adattamento alle condizioni climatiche, l’ingenuo mimetismo alle abitudini murarie della regione, lo studio nel superare la pacata e rozza semplicità con cui si risolvono in modo embrionale ma pur sempre sufficiente le necessità essenziali di un sedile, di una tettoia trasformano l’architettura rurale in un libro di onestà edilizia denso di insegnamento”…
A pianta rettangolare, su due livelli e con la copertura a capanna o a padiglione, il casale testimonia il raro equilibro fra natura e insediamento umano; luogo dove l’uomo ha trovato più facilmente e più spesso rifugio e all’interno del quale ha vissuto le esperienze più profonde di una vita spesso disagiata e dura ma anche piena di attaccamento e di identificazione con la propria terra.
Tenuta Pasanisi – Grande proprietà con 3 casali in pietra, dei quali uno finemente ristrutturato. Spazi esterni curati nei minimi particolari ed impreziositi da una piscina a forma irregolare.
Trullo
I trulli di Puglia, strutture note in tutto il mondo per la loro bellezza ed unicità, rappresentano uno degli esempi più straordinari dell’architettura popolare italiana.
Diffusi su tutto il territorio pugliese, raggiungono la massima concentrazione ed espressione artistica nella Valle d’Itria.
Entrando in questa zona, contraddistinta da morbide ondulazioni collinari coperte di vigneti e di verdi macchie di boschi, rigata da bianchi muretti a secco, punteggiata da case bianche con una bruna copertura a cono, il turista, anche il più distratto, ha la sensazione di essere entrato in un territorio senza tempo, quasi magico.
E questa stessa sensazione la si prova passeggiando tra i vicoli dei paesi della Murgia dei trulli: Alberobello (i cui trulli sono stati dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’intero pianeta), Locorotondo, Cisternino e Martina Franca.
Masseria
Con il termine “masseria” o “massae” indichiamo estensioni di terreno di proprietà privata munite di ricoveri in muratura.
Le masserie sono definibili come ogni forma dell’insediamento umano, nel territorio rurale, centri di produzione e organizzazione del lavoro agrario.